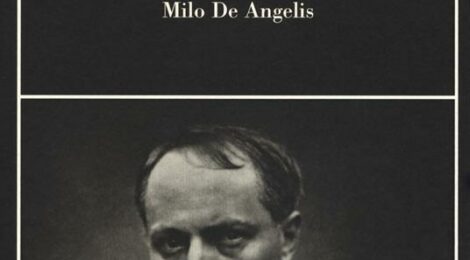
Stefania Brivido – Alienati e alternativi: quando la parola deforma
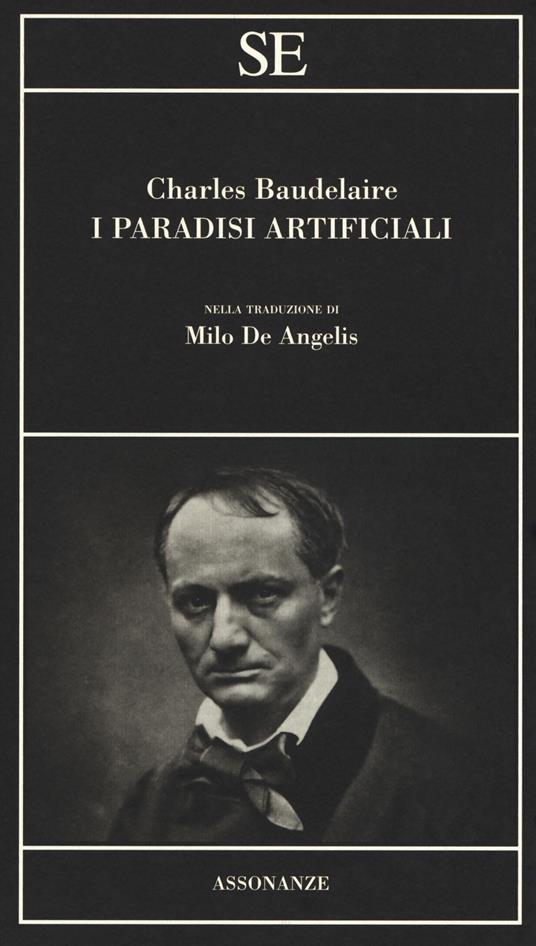
La letteratura internazionale è piena di esempi che trattano il tema delle alterazioni. E in fin dei conti che cosa sono le alterazioni? Sono dei mutamenti di ordine sociale, antropologico, politico e psicologico che caratterizzano l’essere umano. L’essere umano stesso subisce e compie mutamenti, alterazioni che riguardano la propria crescita personale o la società in cui vive. Ma esistono anche alterazioni causate da sostanze allucinogene come le droghe o l’alcol. Nel saggio “Paradisi artificiali”, Charles Baudelaire illustra le alterazioni dell’individuo a casa di droghe come l’hashish o l’oppio. «L’hashish non si concilia con l’azione. Non consola come il vino; non fa che sviluppare oltre misura la personalità umana nelle circostanze in cui si trova al momento» afferma Baudelaire elencando le fasi che seguono all’assunzione della droga. Il momento clou dell’alterazione avviene quando l’individuo è in fase allucinatoria e a volte avviene la scomparsa della personalità: «Si vivono parecchie vite d’uomo nello spazio di un’ora» e l’uomo raggiunge uno stato di felicità paragonabile all’incontro con una divinità o all’identificazione stessa dell’individuo con un dio. Tuttavia, la sostanza resta sempre quello che è, una droga che funge da specchio che ingigantisce le normali impressioni o pensieri dell’individuo.
Nelle sostanze allucinogene e nell’alcol cerca di soddisfare la propria fame di contatto umano, il protagonista del romanzo “Queer” di William S. Burroughs. Lee, alter ego dello scrittore, si abbandona ad una relazione mercenaria in cambio di denaro. L’alterazione causata dall’alcol e dalle droghe – nella seconda metà del romanzo Lee andrà alla ricerca di una droga esotica, detta yage – però non riesce a colmare il profondo desiderio di contatto umano. Il romanzo vuole raccontare una parte della vita di William Burroughs, uno dei padri fondatori della famosa Beat Generation, che amava sperimentare anche attraverso le droghe.
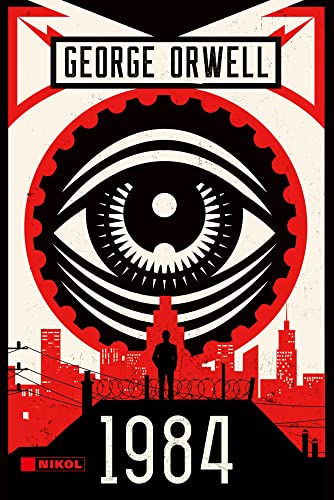
Di alterazioni del pensiero parla George Orwell nel suo romanzo distopico “1984”. Il controllo del pensiero avviene attraverso il Grande Fratello, una serie di schermi forniti di telecamere e presenti nelle abitazioni di tutti i civili. Questo è gestito dal Partito in un regime totalitario che mira ad indebolire il pensiero individuale e critico delle persone attraverso il “bipensiero”, un meccanismo mentale imposto dal Partito. Chi si rifiuta di assoggettarsi al potere del Partito deve subire atroci torture e deve essere incarcerato. Si tratta di un romanzo non solo distopico, ma anche fantapolitico, perché espone le conseguenze del totalitarismo come la censura e la repressione della libertà.E ancora, le alterazioni psicologiche vengono introdotte in letteratura grazie al padre della psicanalisi, Sigmund Freud e un grande esempio è il romanzo di Italo Svevo “La coscienza di Zeno”. che racchiude quasi un diario individuale del protagonista che non riesce a sfuggire al vizio del fumo. Sono gli scrittori russi che iniziarono a trattare delle alterazioni psicologiche che portano ad atti estremi come l’omicidio o il suicidio. Due esempi eclatanti sono “Delitto e castigo” di Fëdor Dostoevskij e “Anna Karenina” di Lev Tolsoj. Il protagonista di “Delitto e castigo”, Raskol’nikov, che premedita due omicidi in tutta lucidità, ma dopo averli compiuti subisce le conseguenze psicologiche del caso: si ammala di febbre cerebrale ed è affetto da dolorosi rimorsi che lo conducono verso una spirale ben peggiore del timore della prigionia in Siberia. Il senso di colpa e il peso dell’angoscia lo conducono verso una solitudine forzata e infine verso una confessione liberatrice e piena di pentimento. Anna Karenina, la protagonista del romanzo di Tolstoj, è una donna che subisce la condanna da parte della società per essere una peccatrice, un’infedele, una donna egoista, un essere spregevole dedito alla vanità e in più viene condannata per il proprio atto estremo: il suicidio. Probabilmente nel suicidio Anna trovò la propria liberazione o forse si trattò soltanto di un atto estremo dettato dall’alterazione psicologica. Tuttavia, è proprio la società a provocare nella donna un tale stato di disordine, di pazzia, da condurla fatidicamente al suicidio.
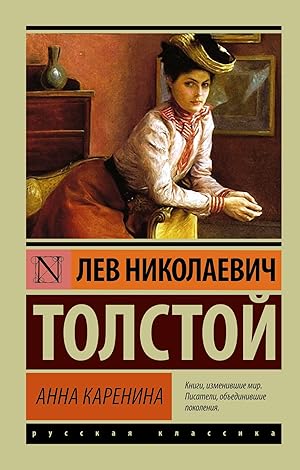
A Tolstoj, comunque, piace giocare con l’espediente del destino e della condanna religiosa, che non ha nulla a che fare con le alterazioni psicologiche. Si può definire questo un romanzo esistenzialista, com’è esistenzialista il protagonista de “La nausea” di Jean Paul Sartre. Il protagonista del romanzo, Roquentin, prova una nausea angosciante nei confronti dell’esistenza, tanto da reputare inutile tutto ciò che lo circonda. La sua è una nausea esistenziale nei confronti di una realtà borghese troppo scomoda e addirittura ridicola. Ciò lo porta a mutare nei confronti del mondo e della società. La stessa visione esistenzialista fu adottata da un grande scrittore italiano, Cesare Pavese, nel suo romanzo “La casa in collina”. Il protagonista del romanzo, Corrado, subisce o meglio decide di subire quella che può intendersi come un’alterazione di tipo politico. Il personaggio all’inizio non sembra propenso a parteggiare per coloro che si adoperano a resistere contro la minaccia fascista e decide di condurre una vita isolata a contatto con la natura su una collina, ignorando la morte e il sangue a Torino, in città. Ben presto però, Corrado prova un certo disgusto di fronte alle ingiustizie umane e decide da quale parte stare. La sua è una presa di posizione ben salda, un mutamento psicologico e politico nei confronti di un mondo che deve essere cambiato. E quando si abbraccia un mutamento ogni timore viene dissipato per lasciare spazio alla comprensione. Anche lo stesso Lee, protagonista di “Queer”, si rende conto di avere alterato il proprio modo di agire attraverso le droghe e l’alcol soltanto per trovare quella consapevolezza di se stesso – della propria omosessualità come essere umano – che non aveva mai accettato o addirittura trovato. E’ positivo o negativo subire o abbracciare delle alterazioni, dei mutamenti? L’unica risposta da dare a questo quesito è che di sicuro si raggiunge una consapevolezza che la letteratura riesce ad insegnarci benissimo.
Stefania Brivido
I commenti sono disabilitati, ma trackbacks e pingbacks sono abilitati.