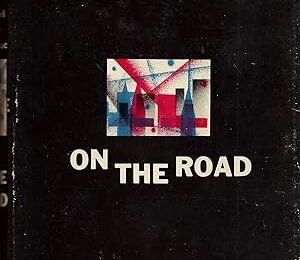
Stefania Brivido – Randagi di carta e dove trovarli
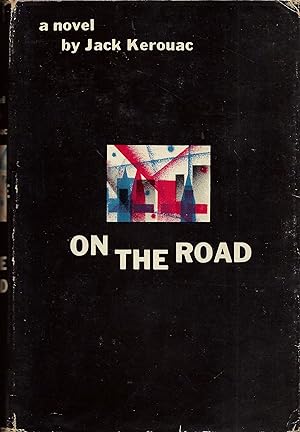
Quando si pensa al randagismo in letteratura, immediatamente viene in mente un romanzo di un autore ben specifico: Jack Kerouac, l’autore dell’acclamatissimo On the road e fondatore, insieme alla guida di William Burroughs, della Beat Generation. Ciò che caratterizza la letteratura della Beat Generation è la ricerca di un randagismo fisico, spirituale e sociale e dunque Jack Kerouac aveva necessità di avventura, di viaggio, di sfiorare il pericolo qualche volta, prima di scrivere di vita. E se vogliamo definire Kerouac come il “randagio alcolista”, ciò va a definire una tipologia di scrittore randagio che necessita anche di bere per giungere ad una rivelazione, intesa spiritualmente e creativamente. Infatti, la beat non è altro che una benedizione, cioè la ricerca di una benedizione che si realizzi nella scrittura. A differenza della Lost Generation, gli esponenti della Beat Generation sono dei ribelli per forza di cose, consapevolmente perché subiscono la disillusione del presente. A dividere le due generazioni vi è la Seconda Guerra Mondiale, mentre la prima ha vissuto entrambe le guerre. La Beat Generation ha radici religiose e spirituali, ma anche sociali e letterarie, basate su un noto testo di Oswald Spengler. Spengler, nel suo Il tramonto dell’Occidente descrive la fine catastrofica dell’evoluzione culturale attraverso il fenomeno della civilizzazione, che conduce alla perdita dell’armonia tra l’uomo e la natura. Il senso di avventura e il senso di vita vissuta energicamente si possono ben ravvisare all’interno di On the road, incontrandovi anche riferimenti biografici molto seri e al contempo avventurosi, come ad esempio il coinvolgimento di Kerouac nella faccenda sanguinolenta tra Lucien Carr e del professor Kammerer, ai tempi del College a Chicago (di questa faccenda si può leggere nel romanzo intitolato E gli ippopotami si sono lessati nelle loro vasche scritto da Kerouac e Burroughs) . Non c’è avventura se non c’è pericolo e sangue, dunque soprattutto per uno come Jack Kerouac. Di sangue e di pericolo sono costellati i romanzi di Cormac McCarthy, che presentano eroi emarginati in continuo contatto con una natura impervia. McCarthy fu pubblicato per la prima volta dallo stesso editore di Faulkner, uno dei pilastri della letteratura nord-americana. Le palme selvagge, romanzo pubblicato da William Faulkner nel 1939, è narrato a capitoli alterni dal punto di vista di due protagonisti randagi, randagi della società, costretti a fare i conti con il proprio senso di miseria: il primo un carcerato che salva una donna incinta durante l’inondazione del Mississippi e il secondo un giovane studente di medicina che si innamora follemente di una giovane donna sposata e intraprende un rapporto sentimentale con lei, giungendo così entrambi all’autodistruzione. Il romanzo racchiude il senso di rifiuto di una società che porta i protagonisti, persone comuni, a fare i patti con un senso profondo di miseria personale, spirituale e fisico così palpabile da diventare insopportabile. E proprio quei randagi della società sono delle palme selvagge scosse dal vento, a volte impetuoso, e che non potranno mai essere sradicate dal terreno. Randagio “culturale” può essere definito Elias Canetti, scrittore di tutte le nazionalità e figlio della Mitteleuropa, nato in Bulgaria, di origine ebraica di ascendenza sefardita, turca ed italiana. Fin da bambino, in casa parlava molte lingue come il giudeo-spagnolo, il tedesco e l’inglese. Durante la sua vita viaggiò spesso, perché ogni vita è il centro del mondo e soprattutto perché costretto a fuggire dalla minaccia nazista. Visse in Svizzera, a Francoforte, a Vienna, a Strasburgo, a Parigi e a Londra. Scrisse diverse opere, ma principalmente si occupò per gran parte della vita di studiare la massa a livello sociale: da tale studi nacquero Massa e potere e il suo unico romanzo Auto da fé.
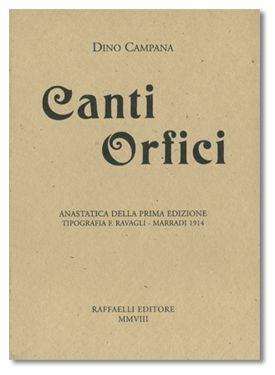
Ma i randagi letterari per eccellenza sono i poeti come Rimbaud e Valery, dai quali trassero ispirazione anche i maggiori rappresentanti della Beat Generation. I poeti sono girovaghi, naviganti e viaggiatori perché la poesia necessita di cammino, di scoperta, di avventure e disavventure. Un poeta che necessitò di cammino fin dai primi segni della malattia fu Dino Campana, originario di Marradi, che raccontò al medico Pariani di essersi rotto ad un certo punto della sua vita e di avere iniziato a camminare per chilometri e chilometri, per strade e sentieri, compiendo pellegrinaggi. Per comporre i Canti Orfici, Dino Campana fu un poeta errante, un poeta randagio per sé e per il mondo. Fin dalla giovinezza amava vagare per i campi e per le montagne, solitario e riflessivo. Nella sua poesia, i passi erano necessari perché senza il viaggio non poteva realizzarsi il sogno d’amore della “memoria orfica”. Dino Campana è il viandante nietzschiano per eccellenza, perfettamente paragonabile a Dante, che affronta l’Inferno per giungere alla purificazione del Paradiso. Ma ci si domanda se in Dino Campana e in particolare nei Canti Orfici ci sia il ritorno: il ritorno è l’eterna Chimera. Forse il ritorno è soltanto metaforico e ciò che più importa al poeta Dino Campana è soltanto il viaggio in sé. E se in fondo per scrivere è necessario vivere, un vivere inteso come un insieme di esperienze pericolose, stratosferiche, eccitanti ed elettrizzanti o esperienze culturali vitali, si comprende benissimo quanto di loro, questi scrittori e poeti, volessero mostrare e lasciare ai posteri, ai lettori. E se noi lettori proviamo arricchimento nutrendoci di queste letture, vuol dire che anche noi ci sentiamo un po’ randagi della vita e della società e desideriamo evadere alla ricerca di qualcosa a tutti i costi.
Stefania Brivido
Commenti recenti